
Inferno Canto 7°
cerchio IV - V
Avari Prodighi Iracondi


Il tema della Fortuna
«Pape Satàn, pape Satàn aleppe!~ »,
cominciò Pluto con la voce chioccia;
e quel savio gentil, che tutto seppe,
disse per confortarmi: «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch'elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia».
Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia,
e disse: «Taci, maladetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.
Non è sanza cagion l'andare al cupo:
vuolsi ne l'alto, là dove Michele
fé la vendetta del superbo strupo».
Quali dal vento le gonfiate vele
caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca,
tal cadde a terra la fiera crudele.
Così scendemmo ne la quarta lacca
pigliando più de la dolente ripa
che 'l mal de l'universo tutto insacca.
Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa
nove travaglie e pene quant'io viddi?
e perché nostra colpa sì ne scipa?
Come fa l'onda là sovra Cariddi,
che si frange con quella in cui s'intoppa,
così convien che qui la gente riddi.
Qui vid'i' gente più ch'altrove troppa,
e d'una parte e d'altra, con grand'urli,
voltando pesi per forza di poppa.
Percoteansi 'ncontro; e poscia pur lì
si rivolgea ciascun, voltando a retro,
gridando: «Perché tieni?» e «Perché burli?».
Così tornavan per lo cerchio tetro
da ogne mano a l'opposito punto,
gridandosi anche loro ontoso metro;
poi si volgea ciascun, quand'era giunto,
per lo suo mezzo cerchio a l'altra giostra.
E io, ch'avea lo cor quasi compunto,
dissi: «Maestro mio, or mi dimostra
che gente è questa, e se tutti fuor cherci
questi chercuti a la sinistra nostra».
Ed elli a me: «Tutti quanti fuor guerci
sì de la mente in la vita primaia,
che con misura nullo spendio ferci.
Assai la voce lor chiaro l'abbaia
quando vegnono a' due punti del cerchio
dove colpa contraria li dispaia.
Questi fuor cherci, che non han coperchio
piloso al capo, e papi e cardinali,
in cui usa avarizia il suo soperchio».
E io: «Maestro, tra questi cotali
dovre' io ben riconoscere alcuni
che furo immondi di cotesti mali».
Ed elli a me: «Vano pensiero aduni:
la sconoscente vita che i fé sozzi
ad ogne conoscenza or li fa bruni.
In etterno verranno a li due cozzi:
questi resurgeranno del sepulcro
col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi.
Mal dare e mal tener lo mondo pulcro
ha tolto loro, e posti a questa zuffa:
qual ella sia, parole non ci appulcro.
Or puoi, figliuol, veder la corta buffa
d'i ben che son commessi a la fortuna,
per che l'umana gente si rabbuffa;
ché tutto l'oro ch'è sotto la luna
e che già fu, di quest'anime stanche
non poterebbe farne posare una».
«Maestro mio», diss'io, «or mi dì anche:
questa fortuna di che tu mi tocche,
che è, che i ben del mondo ha sì tra branche?»
E quelli a me: «Oh creature sciocche,
quanta ignoranza è quella che v'offende!
Or vo' che tu mia sentenza ne 'mbocche.
Colui lo cui saver tutto trascende,
fece li cieli e diè lor chi conduce
sì ch'ogne parte ad ogne parte splende,
distribuendo igualmente la luce.
Similemente a li splendor mondani
ordinò general ministra e duce
che permutasse a tempo li ben vani
di gente in gente e d'uno in altro sangue,
oltre la difension d'i senni umani;
per ch'una gente impera e l'altra langue,
seguendo lo giudicio di costei,
che è occulto come in erba l'angue.
Vostro saver non ha contasto a lei:
questa provede, giudica, e persegue
suo regno come il loro li altri dèi.
Le sue permutazion non hanno triegue;
necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.
Quest'è colei ch'è tanto posta in croce
pur da color che le dovrien dar lode,
dandole biasmo a torto e mala voce;
ma ella s'è beata e ciò non ode:
con l'altre prime creature lieta
volve sua spera e beata si gode.
Or discendiamo omai a maggior pieta;
già ogne stella cade che saliva
quand'io mi mossi, e 'l troppo star si vieta».
Noi ricidemmo il cerchio a l'altra riva
sovr'una fonte che bolle e riversa
per un fossato che da lei deriva.
L'acqua era buia assai più che persa;
e noi, in compagnia de l'onde bige,
intrammo giù per una via diversa.
In la palude va c'ha nome Stige
questo tristo ruscel, quand'è disceso
al piè de le maligne piagge grige.
E io, che di mirare stava inteso,
vidi genti fangose in quel pantano,
ignude tutte, con sembiante offeso.
Queste si percotean non pur con mano,
ma con la testa e col petto e coi piedi,
troncandosi co' denti a brano a brano.
Lo buon maestro disse: «Figlio, or vedi
l'anime di color cui vinse l'ira;
e anche vo' che tu per certo credi
che sotto l'acqua è gente che sospira,
e fanno pullular quest'acqua al summo,
come l'occhio ti dice, u' che s'aggira.
Fitti nel limo, dicon: «Tristi fummo
ne l'aere dolce che dal sol s'allegra,
portando dentro accidioso fummo:
or ci attristiam ne la belletta negra».
Quest'inno si gorgoglian ne la strozza,
ché dir nol posson con parola integra».
Così girammo de la lorda pozza
grand'arco tra la ripa secca e 'l mézzo,
con li occhi vòlti a chi del fango ingozza.
Venimmo al piè d'una torre al da sezzo.
“Papé Satàn, papé Satàn, aleppe!”,
gridò Pluto con la sua voce rauca non appena ci vide;
ed il gentile uomo saggio, Virgilio, a cui nulla è sconosciuto,
disse allora per confortarmi: “Non ti nuoccia
la tua paura; perché, qualunque sia il potere del demone ,
non ci potrà impedire di scendere da questa roccia.”
Poi si rivolse a quel muso rabbioso
e disse: “Taci, lupo maledetto!
Consumati dentro te stesso con la tua rabbia.
Non è senza motivo il nostro viaggio in queste tenebre:
è stato deciso così in cielo, là dove san Michele
vendicò la violenta ribellione contro Dio degli angeli ribelli.”
Come a volte le vele prima gonfiate dal vento, cadono poi
su se stesse dopo che l’albero della nave si è spezzato, allo
stesso modo si accasciò subito a terra quel mostro crudele.
Liberata la via, scendemmo nella quarta fossa dell’inferno,
scendendo sempre più lungo il pendio di quell’abisso doloroso,
che rinchiude tutto il male dell’universo.
Ah giustizia di Dio! Chi mai può reccimolare
nuovi travagli e pene quante ne vidi io?
E perché la nostra colpa ci sciupa tanto con il male che causa?
Come fanno le onde sopra Cariddi, che si infrangono
contro quelle che incontrano dal lato opposto, allo stesso modo
devono girare in tondo ed urtarsi in eterno le anime dannate del quarto cerchio.
Vidi più gente qui che in qualunque altro luogo;
divisa in due schiere (avari e spendaccioni), chi in un senso e chi nell’altro,
con grandi urla, facevano rotolare in cerchio dei macigni con la forza del loro petto.
Si scontravano tra loro; e poi, sul luogo stesso dell’urto,
ognuno si voltava, respingendo indietro il peso,
e gridando all’avversario: “Perché tieni?” e “Perché sperperi?”
Tornavano infine, movendosi attraverso quel cupo cerchio,
da ogni direzione ai punti opposti di partenza,
gridandosi dietro vicendevolmente sempre la stessa infamante cantilena;
poi ciascuno, dopo essere tornato indietro, si voltava
lungo il suo mezzo cerchio per lo scontro successivo.
Io, avendo il cuore quasi trafitto da quella vista,
dissi: “Mio maestro, dimmi
che gente è questa, e se furono tutti ecclesiastici
questi uomini con la chierica alla nostra sinistra.”
E Virgilio mi rispose: “Tutti quanti, sia a destra che a sinistra,
furono di mente tanto stolta nella loro vita terrena,
da non sapere spendere la loro ricchezza nella giusta misura.
E lo manifestano molto bene gridandosi dietro come cani
quando si vengono ad urtare ai due punti estremi del cerchio,
dove poi vengono separati, avendo commesso colpe tra loro contrarie.
Questi, che non hanno capelli a coprire il cranio, furono
ecclesiastici, e tra di loro ci sono papi e cardinali,
nel quali l’avarizia è solita prevalere facilmente.”
Ripresi io: “Maestro, tra questi ecclesiastici
dovrei io ben riuscire a riconoscerne alcuni,
che si macchiarono in vita di simili peccati.”
Mi rispose Virgilio: “Hai per la testa un pensiero vano:
la loro vita non saggia che li imbruttì in terra,
ora li rende completamente irriconoscibili.
Si scontreranno per l’eternità ai due punti opposti del cerchio:
gli spendaccioni risorgeranno dalle loro tombe
con i pugni chiusi, gli avari con il capo rasato.
Il dare e l’accumulare senza giusta misura ha tolto loro
il paradiso, condannandoli a questa eterna lotta:
la vedi tu stesso, io non aggiungo belle parole.
Puoi così ora vedere, figliolo, quanto sia breve l’inganno
dei beni terreni, la cui distribuzione è affidata alla fortuna,
e per avere i quali la gente si azzuffa;
poiché nemmeno tutto l’oro che si trova al mondo e che vi si
è mai trovato nel passato, a nessuna di queste anime stanche
potrebbe ora procurare un attimo di riposo.”
Si scontreranno per l’eternità ai due punti opposti del cerchio:
gli spendaccioni risorgeranno dalle loro tombe
con i pugni chiusi, gli avari con il capo rasato.
Il dare e l’accumulare senza giusta misura ha tolto loro
il paradiso, condannandoli a questa eterna lotta:
la vedi tu stesso, io non aggiungo belle parole.
Puoi così ora vedere, figliolo, quanto sia breve l’inganno
dei beni terreni, la cui distribuzione è affidata alla fortuna,
e per avere i quali la gente si azzuffa;
poiché nemmeno tutto l’oro che si trova al mondo e che vi si
è mai trovato nel passato, a nessuna di queste anime stanche
potrebbe ora procurare un attimo di riposo.”
Dissi allora io: “Mio Maestro, dimmi anche un’altra cosa:
che cosa è questa fortuna alla quale hai accennato,
che tiene tra i suoi artigli i beni del mondo?”
Mi rispose allora Virgilio: “Oh creature sciocche,
quanto è grande l’ignoranze che vi molesta!
Ora voglio che tu comprenda bene il seguente concetto.
Dio, che con il suo sapere supera ogni cosa, ha creato i vari
cieli mobili ed affidato ad ognuno di essi un angelo, così che
ciascuno dei nove cieli risplenda su ogni parte dell’universo
e distribuisca dappertutto la sua luce in modo uniforme. Allo
stesso modo per gli splendori mondani, per le ricchezze,
Dio ha incaricato la Fortuna come amministratrice e giudice,
con l’incarico di variare il loro possesso, a tempo debito,
da popolo a popolo e da famiglia a famiglia,
senza che l’astuzia umana le possa opporre resistenza;
ecco perché in certi periodo una nazione è dominante e l’altra
è decadente, ed è sulla base del verdetto della Fortuna,
a noi oscuro come lo è un serpente tra l’erba.
Il vostro sapere non può essere in grado di opporsi a lei:
essa accudisce, giudica ed esercita il suo potere
allo stesso modo degli altri angeli, signori dei cieli.
I mutamenti da lei imposti sono continui: è per una necessità
occulta che deve essere veloce nel mutare; tanto spesso
si ha perciò l’occasione di cambiare condizione.
Questa, la Fortuna, è colei che così spesso viene messa in
croce anche da chi dovrebbe invece lodarla,
mentre al contrario viene accusata e diffamata a torto;
essa però sa di svolgere il volere di Dio e non si cura di tali
voci: tutta contenta, insieme agli altri angeli,
fa girare la sua sfera e si gode la sua beatitudine.
Ma scendiamo adesso verso maggiori tormenti; cominciano
già a declinare le stelle che sorgevano in cielo quando iniziai con te
questo viaggio, e non ci è consentito di soffermarci troppo a lungo.
Tagliammo il cerchio degli avari per raggiungere l’altra
sponda, là dove un fonte ribolle e riversa in eterno
le sue acque giù per una fossa che lei stessa ha scavato.
L’acqua era molto più scura che limpida;
e noi, seguendo il corso delle acque scure,
scendemmo verso il basso lungo una via impervia.
Questo triste ruscello sbocca nella palude che prende
il nome di Stige, dopo essere disceso
ai piedi di quelle grigie rocce scoscese.
Ed io, che ero attento nell’osservare,
vidi delle anime infangate in quel pantano,
tutte nude e con aspetto adirato.
Si percotevano tra loro non solo utilizzando le mani,
ma anche con la testa, con il petto e con i piedi,
facendosi letteralmente a brandelli con i denti.
Il mio saggio maestro mi disse: “Figliolo, quelle che vedi ora
sono le anime di coloro che si lasciarono sopraffare dall’ira;
e voglio anche che tu sappia per certo
che ci sono persone immerse in quell’acqua, che con il loro
respiro la fanno bollire in superficie,
come puoi ben vedere con i tuoi occhi ovunque tu ti rivolga.
Immersi nella melma vanno dicendo: “Fummo tristi quando
vivevamo in terra, in quell’aria dolce e rallegrata dai
raggi del sole, portando in noi la fumosa ira:
ora ci disperiamo in eterno in questa lurida melma.” Questa
canzone riescono solo a gorgogliarla, non potendo pronunciarla
con parole intere (avendo la gola ingozzata di fango).”
Percorremmo allora un lungo tratto di quella lurida pozza,
proseguendo tra il pantano e la riva asciutta, tenendo sempre
i nostri occhi rivolti alle anime condannate d ingozzarsi con il fango.
Giungemmo infine ai piedi di una torre.

Pluto. Dio della ricchezza, figlio di Giasone e di Demetra. Era nato a Creta. Figurava inizialmente nel seguito di Demetra e di Persefone, sotto le sembianze di un bel giovane oppure d’un fanciullo che porta un corno dell’abbondanza.
Più tardi, con lo sviluppo della ricchezza mobiliare, Pluto si distaccò dal gruppo di Demetra e diventò la personificazione della ricchezza in genere.
A lui è consacrata la forma sotto la quale interviene nella commedia d’Aristofane. Pluto è rappresentato dai comici (e dalla saggezza popolare) come cieco, poiché fa visita indifferentemente ai buoni come ai cattivi.
Secondo Aristofane, Zeus stesso avrebbe accecato Pluto, per impedirgli di ricompensare le persone dabbene e costringerlo così a favorire i cattivi. Ma siamo più nel campo della simbologia che del mito (Es. Teog. 969 55.; Diod. Sic. 5,49; Inno om. a Dem. 486. Aristof. Plut. passim.,).
Dante né fa un demone, con la tecnica collaudata di insistere su particolari realistici o grotteschi, come la voce chioccia o le enfiate labbia.

Si tratta del primo canto in cui la struttura letteraria non corrisponde a quella topografica e figurativa, per cui ogni canto e occupato da un solo cerchio infernale.
Il settimo canto accoglie infatti il quarto e il quinto cerchio, e nel passaggio dall’uno all’altro si inserisce una pausa, che diventerà tipica, di carattere dottrinario (appunto la disquisizione sulla Fortuna).
Da notare, inoltre, che nel medesimo cerchio sono punite due categorie di peccatori, unite dalla correlazione della colpa per contrasto (avari/prodighi – iracondi/accidiosi).

Tra i dannati di questo cerchio degli avari e prodighi, Dante non riconosce nessuno. Al di là della spiegazione dottrinaria di Virgilio (essi furono ciechi alla conoscenza, cosi ora sono irriconoscibili), l’autore non cita alcun personaggio perché la sua condanna coinvolge l’intero organismo ecclesiastico, reo di una delle colpe più gravi, a giudizio di Dante: l’avarizia.
La Chiesa, in questo canto e nell’opera tutta, si è quindi macchiata del peccato maggiore, proprio quello simboleggiato nel canto I dalla lupa, la fiera che più delle altre costringe Dante a retrocedere dalla strada della salvezza.
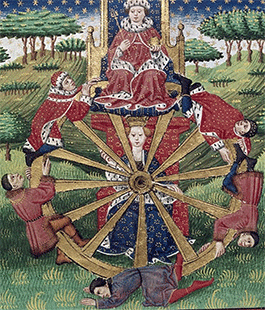
Il concetto di Fortuna. La colpa degli avari e dei prodighi, che non seppero avere un rapporto giusto con i beni naturali, è occasione per inserire la questione dottrinaria sul concetto di Fortuna, che è anche una pausa, un respiro più lungo nella narrazione.
Dante qui modifica la concezione diffusa nel Medioevo ed ereditata dal mondo classico, trasformando la dea capricciosa[3] in una intelligenza celeste, in uno strumento della Provvidenza divina.
Così la ruota della Fortuna che cambia le sorti degli uomini e dei popoli diventa una sfera, al pari delle sfere celesti, e la dea è una delle intelligenze motrici dell’universo, quella che presiede ai destini umani e il cui mutevole e rapido agire e voluto da Dio.
Gli uomini non la possono contrastare, perché sarebbe vano qualsiasi tentativo di opporsi al sommo Fattore.
Questo è il monito che Dante, attraverso le parole di Virgilio, lancia alla presunzione umana, e originale è la collocazione, filosofico-teologica, di un concetto cosi squisitamente terreno.3)

La struttura del canto. Si tratta del primo canto in cui la struttura letteraria non corrisponde a quella topografica e figurativa, per cui ogni canto e occupato da un solo cerchio infernale.
Il settimo canto accoglie infatti il quarto e il quinto cerchio, e nel passaggio dall’uno all’altro si inserisce una pausa, che diventerà tipica, di carattere dottrinario (appunto la disquisizione sulla Fortuna).
Da notare, inoltre, che nel medesimo cerchio sono punite due categorie di peccatori, unite dalla correlazione della colpa per contrasto (avari/prodighi – iracondi/accidiosi).

Il Generale degli angeli è colui che difende la Fede, la Verità e la Chiesa. Dante illustra mirabilmente la bellezza e la potenza di questo Principe celeste e la sua solerzia nel proteggere il genere umano dalle insidie di Satana. Alla fine del Canto VIII della prima Cantica, Dante e Virgilio sono di fronte alla città infernale di Dite, sbarrata al loro passaggio. Sarà l’intervento autorevole di San Michele, che punì il superbo atto di violenza degli spiriti ribelli, a spalancare le porte per far procedere i due viaggiatori. Nelle litanie dei Santi pregate in Purgatorio da coloro che in terra furono invidiosi, San Michele è il secondo nominato, nella Divina Commedia, dopo Maria Santissima, segno del suo grande potere di intercessione.